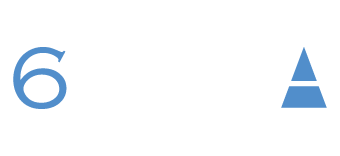Le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro: l’importanza di fare rete tra gli stakeholder istituzionali
A cura di Angela Pisciotta
Sono più di un milione le donne che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Rappresentano l’8,9% per cento delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione. Nei tre anni precedenti all’indagine, ovvero fra il 2013 e il 2016, hanno subito questi episodi oltre 425 mila donne (il 2,7%).
La percentuale di coloro che hanno subito molestie o ricatti sessuali sul lavoro negli ultimi tre anni è maggiore della media del 2,7% tra le donne da 25 a 34 anni (3,1%) e fra le 35-44enni (3,3%) .
Con riferimento ai soli ricatti sessuali sul lavoro, sono un milione 173 mila (il 7,5%) le donne che nel corso della loro vita lavorativa sono state sottoposte a qualche tipo di ricatto sessuale per ottenere un lavoro o per mantenerlo o per ottenere progressioni nella loro carriera. Negli ultimi tre anni, invece, il dato risulta in lieve diminuzione: sono infatti 167 mila, pari all’1,1%, le donne che li hanno subiti.
Il fenomeno dei ricatti sessuali appare più frequente al centro Italia, nei grandi comuni delle aree metropolitane e in quelli con più di 50 mila abitanti.
Il 32,4% dei ricatti sessuali viene ripetuto quotidianamente o più volte alla settimana, mentre il 17,4% si verifica all’incirca una volta a settimana, il 29,4% qualche volta al mese e il 19,2% ancora più raramente. Negli ultimi tre anni, la quota di donne che ha subito ricatti tutti i giorni o una volta a settimana è ancora maggiore (rispettivamente, il 24,8% e il 33,6%).
Quando una donna subisce un ricatto sessuale, nel 80,9% dei casi non ne parla con nessuno sul posto di lavoro.
Quasi nessuna ha denunciato il fatto alle Forze dell’Ordine: appena lo 0,7% delle vittime di ricatti nel corso della vita (l’1,2% negli ultimi tre anni). Un dato che si riduce ulteriormente se si considera chi ha poi effettivamente firmato un verbale di denuncia, il 77,1% di chi ha dichiarato di essersi rivolto alle Forze di polizia.
Le motivazioni più frequenti per non denunciare il ricatto subito nel corso della vita sono la scarsa gravità dell’episodio (27,4%) e la mancanza di fiducia nelle forze dell’ordine o la loro impossibilità di agire (23,4%).
Il ricatto è stato grave per la maggior parte delle vittime: lo ritiene molto o abbastanza grave il 69,6% delle vittime e il 72,8% delle donne che li hanno subiti negli ultimi tre anni.
Il 24,2% delle donne che hanno subito ricatti nel corso della vita (il 36,9% negli ultimi tre anni) ha preferito non rispondere alla domanda su quale sia stato l’esito del fatto. Tra coloro che hanno subito i ricatti nel corso della vita e hanno risposto al quesito, il 33,8% delle donne ha cambiato volontariamente lavoro o ha rinunciato alla carriera , il 10,9% è stata licenziata o messa in cassa integrazione o non è stata assunta.
La collaborazione con il Comitato Imprenditoria Femminile e della Consigliera di Fiducia della Camera di Commercio di Palermo ed Enna
Il Comitato avendo come “mission” quella di favorire l’empowerment delle donne nel loro percorso di lavoro, ha deciso di aderire e supportare il progetto dell’Osservatorio digitale “6libera.org” promosso dalla Presidente Confapi Sicilia, Avv. Dhebora Mirabelli, in qualità anche di membro del Comitato di Imprenditoria femminile e di Consigliera di Fiducia neo-eletta.
Compito del Comitato sarà quello di promuovere presso tutte le associazioni datoriali rappresentate, nonché presso tutte le aziende iscritte la sottoscrizione della dichiarazione di inaccettabilità per promuovere realtà economiche e produttive sempre più etiche e il loro ruolo di protagonista nella lotta alla violenza di genere consumata nei luoghi di lavoro.
Riteniamo che il “silenzio” e la “paura di denunciare” per non subire ritorsioni debbano essere combattuti in maniera forte e allo stesso tempo riteniamo che le aziende si impegnino a creare tutte le condizioni affinché si lavori in sicurezza, vigilando su comportamenti scomposti.
Lo studio sull’uso della tecnologia block chain su cui si fonda lo sviluppo dei progetti connessi dell’Osservatorio viene in aiuto di tali problematiche garantendo la riservatezza e l’anonimato di chi denuncia.
La raccolta delle denunce, così come i sondaggi tra i lavoratori, serviranno ad attivare percorsi di salvaguardia all’interno delle aziende ma anche come data base dal quale soggetti istituzionali qualificati potranno attingere per elaborare strategie di contrasto a tale terribile fenomeno.
Serve far capire che non bisogna tacere e che bisogna fare emergere, denunciando, atti che ledono le libertà delle donne che lavorano e alle quali non possono oltremodo essere precluse opportunità.
In questo solco il Comitato, recependo la Raccomandazione CEE 92/131, ha inoltre promosso la nomina della Consigliera di Fiducia presso la Camera di Commercio di Palermo e Enna con l’adozione di un codice etico di comportamento da questa redatto mirato a combattere la violenza sui luoghi di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici.
Il lavoro sinergico della Camera di Commercio e della Consigliera di Fiducia, Avv. Dhebora Mirabelli, potrà trovare un valido supporto in questo nuovo strumento che sarà diffuso anche all’interno del personale della stessa per promuovere la pragmatica attuazione del codice di condotta adottato.
La Camera di Commercio di Palermo e di Enna è la prima realtà in Sicilia ad avere adottato tale codice di condotta e uno strumento al suo servizio e sta lavorando per promuoverne l’adozione a livello regionale coinvolgendo tutte le Camere di Commercio territoriali.